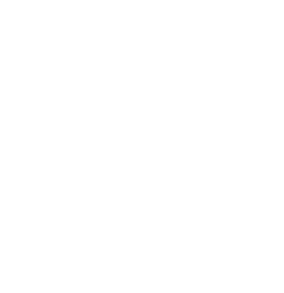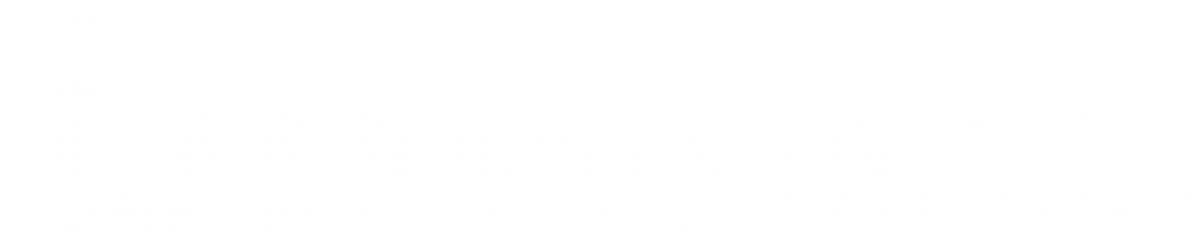In questi giorni il team di bioingegneri composto da Arti Ahluwalia, Carmelo De Maria e Chiara Belmonte si trova a Nairobi per tenere un corso intensivo nell'ambito del progetto Afra Moya, di cui il...
Leggi tuttoProgetto PANACEA - Elena Maggi
La Posidonia oceanica è una pianta marina endemica del Mar Mediterraneo, considerata un indicatore chiave della qualità ambientale dei fondali costieri. Le praterie che forma rappresentano habitat ad alta biodiversità, fungono da serbatoi di carbonio, attenuano l’energia del moto ondoso e svolgono un ruolo cruciale nella stabilizzazione dei sedimenti. Nell’Arcipelago Toscano – in particolare presso l’Isola d’Elba, Capraia e Giannutri – la Posidonia è presente in formazioni più o meno estese, spesso minacciate da pressione antropica crescente, come traffico nautico, ancoraggi e scarichi non controllati.
Per garantire una gestione efficace e sostenibile di queste praterie, è fondamentale monitorarne lo stato di salute in modo regolare, accurato e su scala spaziale significativa. È qui che emerge l’importanza di una sinergia operativa tra biologi marini e ingegneri.
I biologi forniscono le competenze necessarie per interpretare indicatori ecologici quali densità di fasci, morfologia delle foglie, presenza di specie associate. Questi parametri sono fondamentali per valutare lo stato ecologico della prateria.
Tuttavia, il monitoraggio tradizionale tramite rilievi subacquei manuali comporta limiti evidenti: è costoso, richiede tempi lunghi e può coprire solo porzioni limitate del fondale. È in questo contesto che la collaborazione con l’ingegneria diventa strategica. Gli ingegneri, infatti, progettano e sviluppano tecnologie in grado di acquisire dati in maniera efficiente: droni subacquei dotati di videocamere e sonar, sensori di qualità dell’acqua, sistemi GPS subacquei e piattaforme per la georeferenziazione dei rilievi.
Inoltre, l’uso di algoritmi di intelligenza artificiale permette di automatizzare l’analisi delle immagini e di distinguere con elevata accuratezza Posidonia, sabbia o substrati rocciosi. Questa automazione è stata testata all'interno del progetto PANACEA, nei fondali attorno a Cecina e Livorno, riducendo significativamente i tempi di elaborazione dati rispetto ai metodi manuali. L'ambizione di PANACEA, progetto guidato dalle Università di Pisa e di Firenze, è infatti mettere a punto un sistema multirobot in grado di effettuare il monitoraggio di aree estese, fornendo ai biologi dati essenziali su cui lavorare.
L’integrazione tra conoscenza ecologica e capacità tecnologica consente infatti di produrre mappe dettagliate, confrontabili nel tempo e utili per decisioni gestionali basate su dati oggettivi. Solo attraverso una collaborazione strutturata tra discipline diverse – ma complementari – possiamo proteggere efficacemente un ecosistema prezioso come quello delle praterie di Posidonia oceanica dell’Arcipelago Toscano.
Ne parla nel video Elena Maggi, docente di Ecologia all'Università di Pisa, e coordinatrice del progetto AquaPLAN (Aquatic Pollution from Light and Anthropogenic Noise - managment of impacts on biodiversity; www.aquaplan-project.au), che ha prodotto la prima mappa interattiva degli habitat marini europei colpiti dall'inquinamento luminoso e acustico (LNP), incluse le praterie della fanerogama marina Posidonia oceanica in Mediterraneo (link: https://aquaplan-project.eu/